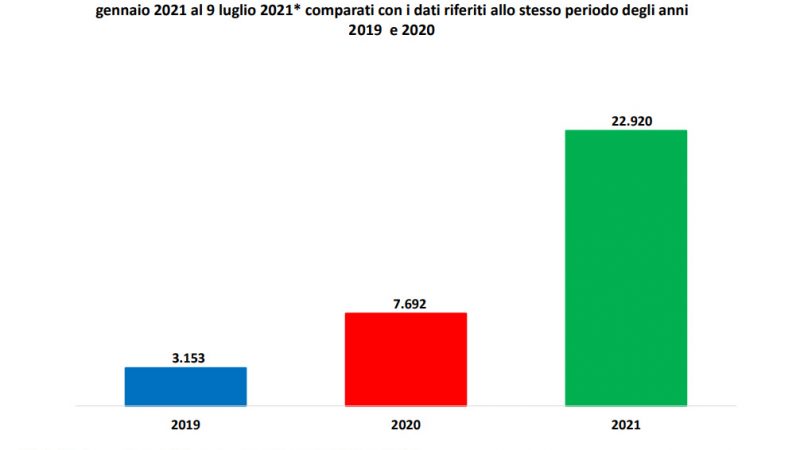“L’identità? Va pensata insieme alla differenza ” intervista a Pietro Barcellona

–Professor Barcellona, leggendo i suoi testi degli ultimi anni, si scorge una analisi sempre più accurata del modello di società occidentale, con accenni fortemente critici. Questo modello, contrassegnato dall’onnipotenza della tecnica e della scienza, da un diritto che si pretende universale e dal primato assoluto dell’economia, comporta conseguenze desolanti: tra le altre, mercificazione dell’esistenza, incomunicabilità, nevrosi, dissoluzione del legame sociale. Lei afferma che viviamo così in una società popolata da atomi egoisti che si rapportano l’uno all’altro secondo il principio dell’astrazione…
A questo proposito, le faccio un esempio che io utilizzo spesso: il rapporto che si instaura tra una madre ed una baby sitter, che riceve una retribuzione fissata da un contratto collettivo, da una legge oppure da un accordo praticato in una determinata zona, è sicuramente un rapporto astratto, perché è un rapporto in cui i due soggetti che si relazionano non lo fanno come due persone, ma come due attori: in questo caso attori di una vendita e di un acquisto di forza lavoro. In un rapporto di vicinato tradizionale – e non c’è in questo nessuna apologia, ma solo una esemplificazione del discorso – avveniva qualcosa di diverso: se una madre aveva bisogno, si presentava alla porta, spiegava i motivi che la spingevano a chiedere aiuto e la ragionevolezza di queste motivazioni venivano valutate dalla vicina: tutto avveniva sulla base di una comprensione reciproca delle rispettive ragioni, ed il rapporto che ne scaturiva non era monetizzabile, non poteva essere definito in termini di quantità astratta, né di semplice retribuzione. Questo esempio lo trovo molto calzante: i rapporti di vicinato sono per antonomasia rapporti fondati sulla fiducia personale, sulla conoscenza, sulla comunicazione; i rapporti monetari sono invece rapporti in cui si mettono in relazione le cose, ma non le persone che le portano. Marx lo ha detto prima di tutti…al mercato ci vanno le cose e non gli uomini, che si riducono a dei trasportatori, dei veicoli, strumenti del movimento. In realtà la circolazione delle merci non è una circolazione dei rapporti umani.
Quindi tutti i rapporti di mercato finiscono per essere rapporti astratti…
Non c’è dubbio… In essi si entra con i ruoli precostituiti di venditore o di compratore, di creditore o di debitore.
Questi rapporti realizzano il miracolo, che gli stessi liberali hanno esaltato, della collaborazione senza comunicazione. Milton Friedman ha dimostrato in Liberi di scegliere come solo grazie al mercato si realizzi questa singolare circostanza per cui due persone, che si trovano magari in zone geografiche completamente diverse e lontane, cooperano senza dover comunicare: il prodotto finale che sarà messo nelle mani del consumatore è frutto comunque di una interazione.
Al di là di tutto ciò che si possa pensare del passato e del presente, non c’è dubbio che gli effetti della trasformazioni produttive, sociali e culturali, che si sono realizzate dopo il crollo del muro di Berlino, hanno messo in evidenza sempre di più la tendenza del mercato a diventare onnivoro, cioè ad esaurire tutta la gamma possibile dei bisogni. Si pensi ad i cosiddetti “bisogni di cura”, che prima venivano risolti nell’ambito di una costituzione familiare abbastanza allargata: adesso sono diventati bisogni mercantili; c’è un nuovo esercito di lavoratori, qualcuno li ha definiti una nuova servitù, che ha il compito di accudire le persone deboli, dagli anziani ai bambini; ed è solo un esempio. In realtà ogni problema esistenziale ha una sua soluzione economica, che il più delle volte non mobilita gli affetti di nessuno, non coinvolge nessuno. La neutralizzazione dell’affettività, delle passioni, del coinvolgimento personale e quindi di tutto ciò che costituisce il mondo della vita è evidente. I rapporti di mercato sono rapporti neutralizzanti, rapporti che spersonalizzano. In questo senso la società è sempre più popolata da atomi egoisti.
– Come il pensiero occidentale è arrivato a concepire questo modello di convivenza?
Alla base di questo pensiero c’è certamente una fantasia onnipotente, quella cioè di immaginare una situazione in cui ogni atomo della società possa costituirsi in maniera autarchica e indipendente da tutto e tutti. Non c’è dubbio che questa fantasia è il culmine di un processo che parte dall’affermazione del logos contro il mito, avvenuto ad opera della filosofia greca: è allora che si assiste all’inizio di un percorso di autarchia e quindi di astrazione.
Il logos si rappresenta come alternativo alla vita materiale, alla natura, a tutto ciò che appare ai primordi come riconducibile a una forza primigenia, a potenze oscure terrestri ed astrae per costituire percorsi razionali verso la sopravvivenza e la conservazione della specie umana… L’astrazione è dunque la negazione di una dipendenza che determinerà il progressivo sganciamento dalla realtà concreta, dalla materialità. L’idea che nel logos fosse implicita la dominazione della natura nasce nel momento in cui i filosofi si contrappongono alle sacerdotesse del mito, alla materialità bruta, e cominciano ad affermare figure di organizzazione della verità essenzialmente patriarcali. Ma è chiaro che nella modernità si assiste ad una fuga in avanti di questo processo: mentre nella società premoderna si vive una sorta di dualismo, di equilibrio, tra l’astrazione del logos e l’esperienza concreta, nella modernità, a partire dall’autocertificazione da parte dell’individuo della propria esistenza attraverso il pensiero di Cartesio, si realizza una separazione dalla natura sempre più accentuata che porta verso un’autarchia tendenzialmente totale. L’individuo si libera dalla comunità. Naturalmente questa è una forma di libertà particolare, che non è partecipare con gli altri, ma separarsi dagli altri per stare soli: la libertà negativa. La libertà come scioglimento dai vincoli e l’astrazione sono identici.
– Se l’individuo si pensa astratto e sciolto da qualunque legame, la vita in comune non è più un dato di fatto, ma va giustificata…
Non a caso, il tema della società nasce con la sociologia, ed è interessante notare come l’autonomia dei saperi è uno dei prodotti dell’astrazione. Tutte le scienze sono nate dalla scorporazione, dalla frantumazione dell’unità della cultura.
In effetti con la modernità emerge il problema del fondamento, della nascita la collettività, della vita in comune ed a ciò si accompagna la nascita dell’individualismo come paradigma dell’esistenza, anche se evidentemente questo non avviene all’improvviso.
Nella Grecia antica c’era l’individuo, che “accadeva” come evento ed il cui elemento caratterizzante emergeva nel corso della vita concreta, relazionandosi agli altri…il problema dell’origine della comunità non si poneva.
Con la modernità, invece, questo problema necessita di una risposta, che è la seguente: il soggetto si autocostituisce e la società si autopone e di conseguenza si separa dal fondamento che in sostanza altro non era che dipendenza da un elemento esterno, fuori dal sociale…dal dio, dalla natura.
Così tutto diviene un atto di autocreazione del soggetto. Il sociale deve risolversi totalmente in se stesso, secondo la logica cartesiana dell’autoriflessione… Ma nel momento in cui si rimuove il fondamento il soggetto stesso dilaga: esso si deve pensare come megasoggetto, soggetto storico marxista, non più riconducibile ad una esperienza storica vissuta.
Tale soggetto astratto non ha rapporti pregressi, perché il legame non è un dato, ma un costrutto derivante dalla volontà. Se l’obbligazione si fonda sulla volontà e non sulla prassi e sulla comunità, essa diviene semplicemente consensuale, quale è quella moderna appunto.
Quindi si pensa un legame sociale artificiale…
Io direi che il legame non può più essere pensato. L’esperienza concreta è fatta di vincoli, di una trama di rapporti, è un’esperienza di doverosità, ma anche di temporalità: vi è un inizio ed una fine. C’è una storia del legame. La modernità, che invece si pensa come pura forma, non può immaginare di dipendere dal legame, perché non può neanche immaginare la sua storia. Essa nasce matura, con l’idea che tutto è già incluso nelle sue premesse, che vanno sviluppate e attuate. Una sorta di rivoluzione permanente che ha un compito astratto: modernizzare, attuare il proprio principio, e cioè diventare uguale a sé stessa. Il suo dna è indeterminato, perché non deve lasciarsi intrappolare dalla concretezza, che è differenza, legame, ma anche fine, morte, soggezione. Se ci pensassimo in relazione al legame, ci dovremmo pensare mortali, esseri naturali, all’interno di uno spazio e di un tempo. La modernità invece non si può pensare superabile…il possibile non è mai esaurito, c’è sempre produzione di possibilità formali, non di contenuto. L’unico vincolo della modernità è realizzare la sua libertà senza limiti.
Questa dissoluzione del legame sociale fa nascere anche l’interrogativo sull’identità, che oggi da più parti si chiede di difendere.
L’identità è un concetto che si presta facilmente ad equivoci e bisogna saperlo declinare: se è pensata nei termini del rapporto tra soggetto e predicato, secondo il principio di non contraddizione, allora l’identità diventa elemento di dominio e chiusura. In questi termini la logica identitaria è una logica tautologica, e da questo punto di vista solo quella moderna è una logica identitaria: l’unico obiettivo è realizzare se stessa, cioè l’identico, il nulla. Ma l’identità non è necessariamente questo, perché essa va relazionata sempre ad una differenza. Se infatti è declinata in termini dialettici, nei quali l’alterità è vissuta non come annichilimento ma come arricchimento, allora diviene elemento costitutivo della personalità. Partendo da questa logica differenzialista, l’identità è sempre rapporto con il differente ed il differente ha la sua stessa dignità. Questa è anche una logica di comunicazione, che porta ad un difendersi reciproco dalla messa in discussione sia delle differenze che delle identità. Pensiamo al vissuto esperenziale di ognuno: questo conosce l’alterità, non come semplice specchio riflesso. Noi siamo persone e dobbiamo poterci rappresentare in termini specificamente individuali. Ma non possiamo essere un semplice prodotto del prototipo di individuo che è stato costruito dalla modernità. In questa ottica il rapporto dell’identità con la differenza è qualcosa di costitutivo, l’essenza stessa della consapevolezza di sé. La consapevolezza di sé, che è frutto di un vissuto esperenziale, non si può dedurre da un’universalità astratta. L’universalità astratta della dottrina giuridica corrente, anzi, distrugge l’identità. Il problema è quindi considerare l’identità insieme alla differenza, altrimenti la sua difesa non è una reazione alla atomizzazione. L’identità deve essere messa in relazione ad un pensiero che fa della differenza un elemento costitutivo, che pensa insieme all’identico anche il diverso.
-La globalizzazione può essere definita a questo punto come il tentativo del modello che ci ha descritto finora, sviluppatosi in occidente, di universalizzarsi. Lo ritiene un processo irreversibile?
Non c’è dubbio che la globalizzazione ha avuto inizio nel momento in cui tutti i pensatori della rivoluzione moderna hanno pensato all’universalismo. Già gli stessi principi del cristianesimo si sono pensati come universali. Nel concetto di mercato è insita la sua globalizzazione ed è chiaro che quando applichiamo la sua logica alle altre culture, stiamo imponendo il nostro modello, cioè stiamo occidentalizzando il mondo. Per me non ci sono processi irreversibili, perché gli uomini non hanno il dominio delle leggi storiche. Come dice Cornelius Castoriadis, l’evoluzione per certi versi è un fatto, ma non è una teoria da cui possiamo ricavare delle leggi di movimento eterne; che oggi siamo arrivati alla globalizzazione è un fatto , ma non è una teoria che ci consente di affermare che il futuro sarà l’universalizzazione planetaria.
– Che ruolo ha lo sviluppo della tecnica nel contesto che Lei ha descritto finora?
La tecnica è figlia del processo di astrazione, ed è sempre esistita. Già nel neolitico nasce l’idea di utensile: dall’uso concreto della pietra che è stato fatto da un cacciatore contro la preda si passa all’ uso stabilizzato dell’arco come strumento. Già nel villaggio neolitico nasce la categoria sociale della tecnica, perché i tecnici lavorano a perfezionare gli strumenti, mentre i cacciatori vanno a caccia. È la divisione del lavoro. Per moltissimo tempo essa è stata guidata socialmente: nasceva dalla produzione sociale che richiedeva strumenti. Ciò che avviene adesso è che la tecnica si è autonomizzata dal rapporto sociale e si è incorporata nel rapporto produttivo. In fin dei conti la tecnica appartiene a quella costruzione del primato della ragione strumentale di cui parlavamo prima, “il mezzo per”, che è il massimo dell’astrazione. Avere il culto dei mezzi prescindendo dai fini, significa avere un’idea dell’astratto come potenza che si distingue, più importante del concreto: un arco ed una freccia valgono più del cacciatore che la tira e della preda che ha preso, perché sono validi di per sé. Se la tecnica si autonomizza, si riflette su se stessa e si realizza quel fenomeno che Severino ha descritto molto bene: l’organizzazione tecnica della tecnica… la tecnica risponde solo alla propria potenza con la conseguenza che tutto ciò che si può fare si fa. L’unico suo fine diviene quello di un autoaccrescimento continuo, per realizzare tutti gli scopi particolari. Ma allo stesso tempo, è una tecnica che si è resa anche completamente autonoma dagli scopi particolari, perché li ha resi asserviti all’unico scopo di aumentare se stessa. Questa tecnica è la potenza assoluta, Dio in terra, direbbe qualcuno.
È un dio in terra che mette in gioco la vita……
La posta in gioco di tutto l’Occidente è sempre stata questa: il controllo della natura, fino a sostituirsi ad essa distruggendola e rendendola superflua. C’è un elemento di volontà di potenza in questo atteggiamento che è stato colto anche dai filosofi, un aspetto perverso, quello di bruciare il terreno sotto i piedi, di rendere impossibile ogni ripensamento, ogni pausa di riflessione. Una volta che le cose sono tecnicamente possibili, l’uomo è tentato di farle e a questo punto è in gioco la vita. Prendiamo ad esempio un tema molto attuale, la produzione della vita attraverso l’uso degli embrioni: questo al di là di ogni opinione religiosa, significa usare la vita come mezzo per produrre la vita stessa. Chiaramente è un processo che finisce per passare attraverso il mercato. Ecco la grande svolta: per la prima volta la vita diventa un mezzo per produrre di più. Brevettando i processi vitali e facendo diventare il vivente un laboratorio per la produzione di denaro.
Ma se logica che ci ha descritto, che soggiace alla tecnica, e quella di un autoaccrescimento senza soluzione di continuità, si può pensare di limitarla?
Il limite non va pensato , ma si deve scoprire. Secondo me non può esservi nessuna argomentazione logica da sviluppare in questo senso. Il limite si farà valere da solo. Quando arrivano lo tsunami ed i terremoti il limite si rivela all’uomo, e si impone.
Quando nasceranno mostri, quando ci accorgeremo che ci sono scappate di mano le cose, oppure saremo talmente infelici da non sopportare l’idea che la nostra vita possa essere determinata da una macchina, solo allora ci fermeremo
Qualcuno potrebbe obiettare che quando ci accorgeremo che ci sono sfuggite di mano le cose sarà troppo tardi… altri affermano che questo è già accaduto.
Io non credo ad un destino malvagio, ma nemmeno ad uno buono. L’uomo è un impasto di cose contraddittorie, vive oscillando tra meraviglia e turpitudine e non penso che potrà combattere l’onnipotenza della tecnica con parole buone o con la persuasione. Si devono affermare una gamma di valori talmente forti da poter contenere la tecnica e questi valori possono nascere solo dall’esperienza.
In alcuni dei suoi ultimi testi, lei a questo proposito fa esplicito riferimento alla riscoperta del sacro.
Ed infatti il sacro non viene inventato. Come tutte ciò che è nascosto può essere ritrovato. Il sacro è sempre presente, in tutto ciò che appartiene all’indicibile della vita. Per esempio, l’esperienza della nascita, il rapporto con la madre, con la quale si entra in uno stato di comunione ma anche di progressiva separazione. E questo processo di ominizzazione non si può dire nelle forme del linguaggio proprio perché prelinguistico…. l’infante è per definizione senza voce. La voce gli viene data dalla madre, quando viene chiamato con il suo nome e declinato come soggetto… così è dalla figura materna, e non da se stesso, che conquista la propria identità. Proprio per questo tale percorso non è riproducibile da una macchina, perché non è logico: è un percorso affettivo e psichico.
Passiamo ad un altro aspetto della globalizzazione, quello dei diritti: si dice spessocce uno degli aspetti positivi di questa universalizzazione è la promozione dei diritti umani. Anche in questo caso sembra all’opera quel processo di astrazione di cui abbiamo discusso.
I diritti umani hanno avuto una funzione pratica: dissolvere quel poco di diritto internazionale che si era creato attraverso i rapporti tra gli stati e cioè il diritto dei trattati. Delegittimare il diritto dei trattati in nome dei diritti dell’uomo significa affidarsi ad una discrezionalità senza confini… Chi decide che cosa è umano?
Giustamente Carl Schmitt ha sottolineato che la difesa dei diritti umani apre la porta ad un arbitrio assoluto. I diritti umani, del resto, non reggono neppure dal punto di vista formale, perché non è possibile immaginare dei diritti senza gerarchia: viene prima il diritto alla vita ed alla sopravvivenza o quello alla libertà? Se si devono mettere in rapporto gerarchico ci deve essere qualcuno che decida: questo qualcuno è il politico; quindi i diritti umani sono una riaffermazione del politico senza alcun limite che non sia il suo stesso arbitrio, perché decidere sui diritti umani significa decidere su quello che deve essere considerato umano e su ciò che va messo fuori dall’umanità. D’altra parte non è possibile tutelare il diritto alla vita senza quello alla sopravvivenza e per soddisfare questo diritto bisogna togliere a qualcuno ciò che possiede, quello che non gli serve e darlo a che non ce l’ha. Già questo è politica.
Eppure da più parti si ritiene che oggi assistiamo alla completa subordinazione della politica rispetto all’economia
Secondo me il problema cammina su due gambe: quella della rappresentazione e quella della realtà. Dal punto di vista della realtà l’economia è sempre più politica, perché organizza la vita con decisioni sostanzialmente politiche e si fonda su un potere, quello militare, degli Stati Uniti che è un potere politico. Noi dovremmo credere alla favola del mercato concorrenziale? Gli economisti che non vogliono mentire sanno che i mercati sono sempre dominati da un oligopolio o da un monopolio e che quindi qualcuno esercita un potere politico, perché chiunque detiene una sovranità sul mercato, smentisce che il mercato è regolatore reale dei rapporti. Quindi ci sarebbe da discutere su come rendere visibile questo potere politico dell’economia.
Se il potere politico è riferibile oggi a soggetti economici, evidentemente c’è da riconsiderare la stessa idea di democrazia. Un potere di questo tipo, anonimo, è fuori dal controllo della collettività. Come i popoli possono riappropriarsene?
La storia ci dice che ci sono due modi: il primo, che per me è il più interessante e che mi appassiona di più, è quello attraverso il quale il cristianesimo ha conquistato l’Europa: un lavoro minuto e molecolare di pedagogia che ha progressivamente sostituito la paideia pagana.
L’altro è quello della insorgenza rivoluzionaria: i popoli rompono la situazione di sudditanza in cui si trovano e fanno la rivoluzione.
Io per la verità, vista la dimensione enorme dei problemi attuali, credo di più alla penetrazione molecolare, ad una rivoluzione che avviene attraverso un piccolo lavoro quotidiano, piccoli gruppi, piccole comunità che cominciano ad attivarsi, un po’ come l’immaginava Gramsci… una rivoluzione che avviene conquistando una per una le case matte e poi smontandole e ricostruendole.
Però non si può non prendere atto che c’è una disaffezione alla politica che viene vista più come uno spettacolo che come un momento di reale partecipazione…
Come una partita di calcio…ma io non sono così sicuro che non ci si possa più appassionare alla politica: il problema è quello di riavvicinarsi alla vita collettiva, alla dimensione autentica dei problemi. Ci sono questioni fondamentali che riguardano tutti noi: penso all’acqua, all’energia. La situazione è a rischio, come affermano alcuni scienziati, che vengono chiamati apocalittici, ma non mi sembra che qualcuno dei loro colleghi sia riuscito a smentirli totalmente Non c’è dubbio che se noi estendessimo il nostro modello di vita a tutto il pianeta, il pianeta non reggerebbe. Quello che mi sembra sbagliato nei giovani è l’atteggiamento di chi si aspetta una risposta, invece di lavorare sullo spazio collettivo che permetta un mutamento di mentalità. Bisogna riaprire lo spazio mentale che renda possibile una visione diversa delle cose, decolonizzare l’immaginario.
-Forse sarebbe necessario lavorare anche ad un nuovo modello politico, visto che quello della modernità, lo stato-nazione, sembra superato dalla globalizzazione. Lei auspica nuove forme di organizzazione politica, per esempio basate sui grandi spazi?
I grandi spazi sono un tema che si è imposto da tempo. Era già stato prefigurato da Schmitt come il problema del futuro. Non c’è dubbio che la forma dello stato nazionale appare inadeguata per immaginare nuovi equilibri mondiali. Mi sembra piuttosto che si possa prefigurare un policentrismo…penso alla Cina e l’India, come forze emergenti. Sarebbe il caso di pensare anche allo spazio europeo, come hanno fatto in tanti che sono stati nazionalisti e si sono convertiti poi all’idea dell’Europa.. Io non credo, insomma, che il futuro sia degli stati nazionali, anche se non penso che spariranno così facilmente. Credo molto nei grandi spazi regionali, all’idea di grandi macroregioni, anche se non si riesce ad immaginare facilmente un’evoluzione in questa direzione.
È vero che la Cina incombe e che l’India ormai è un grande paese modernizzato, ma nessuno riesce ad immaginare che tipo di evoluzione avranno, se si occidentalizzeranno completamente o se conserveranno la loro cultura e in che forma e se la logica che guiderà le loro azioni sarà una logica di conquista, se vi saranno conflitti mondiali. Io credo che, come sempre la possibile svolta in questo senso sarà nei paesi avanzati, come diceva Gramsci. In Occidente c’è già la consapevolezza di un declino mondiale, di un rischio del pianeta, c’è meno ingenuità…se si va in America latina si trovano ancora persone che pensano allo sviluppo ed al progresso come lo immaginavamo noi un secolo fa. Da noi emergono fratture sociali importanti, basta pensare alle ultime proteste in Francia, dove abbiamo assistito alla mobilitazione di un movimento che mira a conservare e non più a distruggere, come avvenne nel ‘68. Ma ripeto lo stato nazionale, anche se è sicuramente in declino, non mi sembra possa concludere la sua parabola così facilmente… gli scenari sono ancora incerti.
Si può sperare nell’Europa?
L’Europa è una grande nazione, e secondo me gli europei esistono già prima dell’unità economica. Per la mia esperienza personale, fatta di viaggi, posso dire che il rapporto che si creava tra europei era un rapporto di comunicazione significativo. C’era, paradossalmente proprio dopo la guerra, una simpatia, si avvertiva un senso di comunità: vi era un confronto reale tra culture; può sembrare assurdo, ma qualche parola di latino la sapevano quasi tutti. Insomma, esisteva un’idea di tradizione comune. Adesso questo sembra perso: c’è americanizzazione, più individualismo, frutto di una visione dell’esistenza in cui ciò che conta è il successo immediato.
Si dovrebbe comunque puntare sull’Europa del popolo europeo, ed insistere su di un’identità europea legata alle tradizioni comuni ed al suo modello sociale. Un’Europa non americanizzata. Bisogna inoltre valorizzare nella costruzione politica dell’Europa, quella tradizione di apertura, dell’incontro, che è propria dello spirito mediterraneo, come dice Massimo Cacciari. Una cultura della comunicazione e dei rapporti di vicinato.
Che ruolo può recitare il Sud Italia in questo scenario?
Il Sud ha una grande occasione adesso, costituita dal fatto che una parte dell’Europa, ed una parte dell’Italia, devono costruirsi un rapporto con il mondo asiatico. il Sud potrebbe essere il ponte. La grande occasione storica è questa. L’alternativa all’America ed ai rapporti che passano attraverso l’a
Atlantico potrebbe essere la strada che passa attraverso il Mediterraneo. Ma tutto questo va pensato, va costruito. Immaginare un’Europa, diventata un’identità politica seria, come interlocutrice dell’Asia e del mondo indiano, è uno sforzo di immaginazione superiore a quello che le nostre classi dirigenti possono compiere attualmente. Però questa occasione c’è, chiaramente: ma solo all’interno dell’Europa degli europei.
a cura di Fabio Pagano