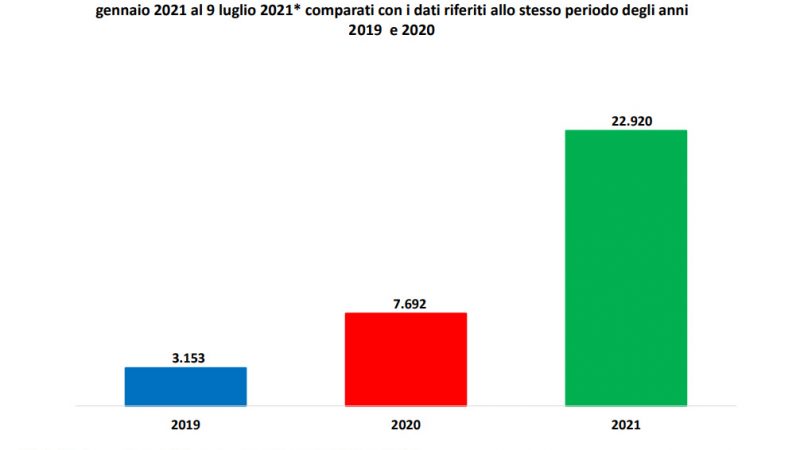E Partenope fischiò l’inno (non Arisa)…

Lo abbiamo già detto e lo ribadiamo: il calcio è la prosecuzione della guerra con altri mezzi. Certo, gli psicologi ci correggeranno e parleranno di “sublimazione”, ma noi, da buoni schmittiani, sappiamo che la politica come lo sport sono, a livelli diversi, forme di neutralizzazione della più intensa contrapposizione esistente, quella tra amico e nemico: per cui, sempre di conflitto si tratta.
Il calcio italico, da questo punto di vista, è davvero rappresentativo: ve ne è una versione moderna, di massa, che monopolizza giornali e televisioni e agita animi tra i più vari, tutti seduti sul divano la domenica pomeriggio e poi al bar o sugli autobus durante la settimana a scontrarsi dialetticamente, sulle virtù del proprio esercito (ovvero la propria squadra). A discutere su notizie di seconda mano, lontani chilometri dal fronte. Chiaramente, in quanto fenomeno di massa, il calcio moderno è business, coacervo di interessi economici che non hanno bisogno di essere celati, ove tutto un mondo campa sull’abilità di ventidue mercenari in pantaloncini corti (dalle pay tv alle grandi agenzie di scommesse, fino all’ultimo commentatore e giornalista). È sempre Schmitt che ci ricorda il tentativo dell’economia di annullare la politica e rimuovere l’idea di “nemico”, rendendolo semplice avversario o, come direbbero gli inglesi, competitor. Ma è un tentativo che quasi mai riesce fino in fondo.
Difatti, vi è un altro calcio, che è fenomeno di élite. Nel senso che è roba per pochi. Perché si dà il caso che alcuni non si accontentano della televisione, per cui si sottraggono per quanto possibile alla società dello spettacolo e decidono di contribuire alla battaglia mettendoci sudore, voce e energia propria, seguendo, ovunque, il proprio esercito (sempre di squadra stiamo parlando). Invadono territori, mostrano fierezza, esibiscono vessilli, rivendicano identità e appartenenze, alzano la voce criticando chi vuole fare del pallone un mero fenomeno di mercato, chi cerca di ingabbiare la nobile e irrazionale passione in uno spettacolo televisivo a cui assistere in pantofole, allo stadio come a casa, magari con famiglia a seguito. Come se si andasse al centro commerciale. Questi maleducati, che atavicamente riconoscono il calcio come fenomeno guerriero e incitano 11 attori pagati a peso d’oro a farsi leoni e a rischiare le caviglie, ne fanno di cotte e di crude e si permettono – incivili – perfino di fischiare l’inno nazionale.
Siamo arrivati al punto. I fatti: domenica 20 giugno, finale di Coppa Italia a Roma, splendida capitale del Belpaese. Da una parte il Napoli, dall’altra la Juventus. Stadio diviso a metà, 35.000 spettatori per squadra. Essendo la coppa cosa nazionale, prima dell’incontro si canta l’inno di Mameli, che tutti ci unisce sotto il tricolore. Questa volta tocca alla bravissima cantante Arisa, che inizia a intonare i versi tanto familiari, mentre dal settore dei napoletani si alzano bordate di fischi, che coprono la bellissima voce della nostra, la quale non sembra aspettarselo e, soprattutto, non capisce perché. Certo, il suo primo pensiero è che sta cantando male, ma poi si rende conto di non essere un soprano alla Scala e, soprattutto, che i fischi sono partiti prima ancora che iniziasse, all’annuncio dello speaker dell’imminente inno. La cosa è davvero incomprensibile, e viene stigmatizzata immediatamente da tutti: televisioni, giornali, Arisa, presidenti del Senato. Tutti concordi nel ritenere quanto successo un atto incivile, ma di fondo senza capire davvero perché è successo.
È che proprio non capiscono che il calcio, quale fenomeno di élite, come la migliore passione politica risveglia identità e appartenenze, restituendo ricordi sopiti anche a chi non sapeva di averne. Nel caso specifico, non comprendendo questa semplice verità, si soffermano – abituati, da buoni borghesi, a neutralizzare tutto ciò che rimescola il sangue nelle vene – sulla negazione (i fischi all’inno) tralasciando l’affermazione. Dimenticando, cioè, che durante e dopo l’inno, i napoletani non hanno solo fischiato ma si sono lasciati andare a un magnifico coro cantato a trentacinquemila voci, formato da tre parole: noi siamo partenopei. Perché, essendo il calcio rappresentazione di guerra, lo stadio, di conseguenza, è campo di battaglia: nel caso di specie, a scontrarsi erano la capitale del glorioso Regno delle Due Sicilie e il simbolo del Piemonte savoiardo (no, non i biscotti). Di fronte ai bianconeri invasori e all’inno che suggella un’Unità nazionale che ancora oggi sconta un vuoto di memoria, Partenope ha voluto ricordare, con orgoglio, quello che la retorica nazionalista e giacobina ha cercato di celare: che prima dell’unità fatta da Garibaldi, le cui gesta sono oggi buone per la triste pubblicità di una compagnia di telefonia mobile (boicottate, partenopei, boicottate) il Regno delle Due Sicilie era il meglio, da svariati punti di vista, che il territorio italico potesse vantare. Che Napoli, città dalla storia millenaria, era una delle capitali europee più splendenti, come tale riconosciuta e apprezzata. Che l’Italia dei Savoia si è fatta sul saccheggio del Sud, depredato di risorse, ricchezze e possibilità per pagare i debiti che i Piemontesi avevano con le banche (corsi e ricorsi storici), con la conseguenza che da allora l’Italia è stato (tranne che per un breve periodo) un paese da sempre diviso. Con buona pace dei luoghi comuni sull’inferiorità culturale e sociale del Regno delle due Sicilie e dei Borbone, allo stadio Olimpico di Roma quelle tre parole, noi siamo partenopei, sono bastate a restituire giustizia e a sottrarre la storia ai vincitori. E’ tutto senza dover democraticamente discutere, portare cifre, dimostrare: tutto questo grazie al calcio. Per cui, cara Arisa, non avrai difficoltà, tu che vieni dalla terra dei Briganti, a ricordare, adesso che sai che il calcio non è sempre solo spettacolo.
In merito all’inno di Mameli, rappresenta l’Italia da poco più di sessant’anni – non certo i più gloriosi della nostra storia – e nemmeno i calciatori della nazionale lo conoscono a memoria. I napoletani, che di canzoni se ne intendono, lo reputano brutto e ne chiedono – a suon di fischi – la sostituzione con qualcosa di più consono e rappresentativo. Il Presidente del Senato, che è uomo del Sud e pertanto acculturato, comprenderà che non di inciviltà si tratta ma proprio del suo contrario. E che, a volte, bisogna pur dare segni di discontinuità con un presente così triste, dove la reputazione dell’Italia fa tristezza, come anche le agenzie di rating ci ricordano.
Pertanto, una proposta: in un momento in cui i tecnici cercano di ridurre il nostro debito pubblico, si cambi l’inno nazionale, magari riscrivendone uno che restituisca gloria anche al Regno delle Due Sicilie, che in epoca preunitaria non ci pare fosse indebitato con le banche. A differenza dei Piemontesi di allora. A differenza degli italiani di oggi.
Chiudo con un omaggio al maestro Giorgio Gaber, uno che aveva capito che la questione è tutta lì. Bisogna decidersi. O avere dei nemici, o giocare a tennis. Lui, Gaber, non aveva dubbi e non lo mandava a dire… “ma giocate al calcio, deficienti!”.