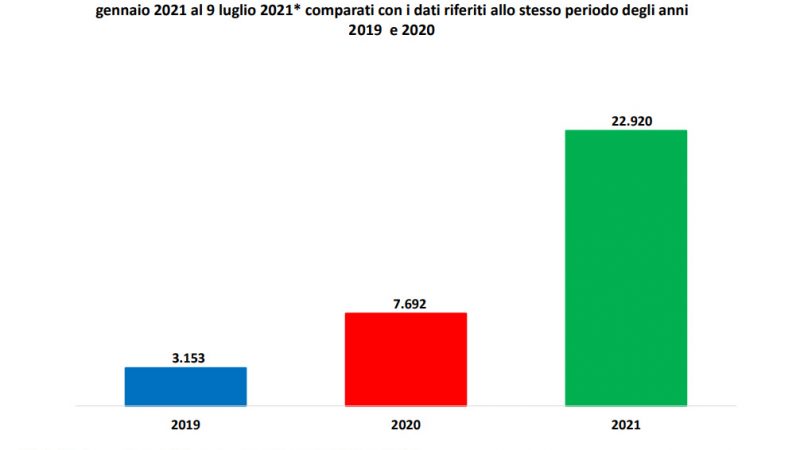Diario del saccheggio italiano

L’usura è il mezzo attraverso il quale il creditore stringe il cappio alla gola dell’insolvente sino a quando, quest’ultimo, non riuscendo più a ripagare il proprio debito, mette in garanzia i beni da cui trae sostentamento, fino a rimanere sul lastrico. Così, il debito pubblico italiano, a marzo 2013, ha toccato il record di 2.034,725 miliardi di euro. A nulla è valsa la tanto osannata austerity del premier tecnico Monti e il ripetere l’ossessivo mantra «ce lo chiede l’Europa» per portare il bilancio in pareggio e per risollevare l’economia. Ci si chiede, allora, quali siano le soluzioni per ripianare il debito pubblico. Come si può far cassa? In ossequio al dogma liberista il metodo migliore è sempre privatizzare, smobilizzare, liberalizzare.
Un processo che in Italia sta durando da circa vent’anni. Precisamente dal giorno in cui si incontrarono sul Britannia, panfilo della regina Elisabetta II, il gotha della finanza internazionale e quello italiano. Era il lontano 1992 ed anche in quel momento i protagonisti erano gli stessi di oggi: Draghi, Ciampi, Amato, Prodi, D’Alema ed in parte l’emergente Silvio Berlusconi. Il ciclone giudiziario creato dalle inchieste del pool Mani Pulite aveva letteralmente spazzato via la classe politica corrotta della Prima Repubblica e creato le condizioni essenziali per consentire l’insediamento di governi tecnici, molto più cinici nel prendere decisioni impolitiche. Secondo gli addetti ai lavori, la decisione di svendere la maggior parte del patrimonio industriale italiano è stata dettata dall’esigenza di ridurre, in primis, il debito pubblico e favorire un azionariato diffuso nella popolazione, rispettare il divieto comunitario di aiuti statali alle società e, di conseguenza, cercare di ridurre il potere dei partiti nelle partecipazioni statali.
Sotto la scure liberista cadono Eni, Enel, Iri, Telecom Italia, Comit, Imi, Ina, Credito Italiano, Autostrade e buona parte dell’industria siderurgica e alimentare pubblica. Il 64,8% delle aziende privatizzate apparteneva ai settori bancario/assicurativo e delle telecomunicazioni, già finanziariamente remunerativi sotto la gestione pubblica. Non erano da considerare un carrozzone di sprechi nemmeno società gioiello come l’Enel, l’Eni o l’Imi che, con sessant’anni di bilanci in positivo, nel 1992 chiude con un attivo di 443 miliardi di lire. In ogni modo, le privatizzazioni non hanno rafforzato la grande industria italiana che doveva essere in grado di affrontare la competizione internazionale. Basti pensare al caso dell’Ilva che, dopo il passaggio in mano al gruppo Riva, non ha più investito in tecnologia, riducendosi allo stato comatoso in cui versa ai nostri giorni. Tra il 1992 e il 2000, quindi, sono stati rastrellati 198 miliardi di lire e, contando che all’inizio del nuovo millennio il debito era di 2.500.000 miliardi di lire, si è avuta solo una riduzione del 7,92%. Eppure negli anni settanta l’Italia poteva vantare una crescita industriale del +6,5% davanti a diversi stati europei, superando per giunta l’Inghilterra nel rango di potenza economica.
Tuttavia se volessimo fare un’analisi retrospettiva, potremmo indicare il 1971 quale data cardine dell’inizio della crisi attuale. L’abbandono degli accordi di Bretton Woods da parte degli USA del presidente Nixon e il conseguente dilagare a livello mondiale di dollari sganciati da qualsiasi valore aureo. Dopo la fine del Glorious Thirty si è dato il via libera alle teorie sul laissez-faire della Scuola di Chicago ispiratrici delle politiche dei governi Reagan e Thatcher, per non parlare del Cile di Augusto Pinochet. A livello mondiale si propugnerà la creazione di un modello di sviluppo incarnato dal diktat degli «aggiustamenti strutturali» del Washington consensus, la spada di Damocle che il Fondo Monetario Internazionale e la Banca Mondiale faranno pendere sui paesi in via di sviluppo (a tal proposito è interessante il libro “Confessioni di un sicario dell’economia” di John Perkins). L’esito più eclatante di questa politica sarà l’esplosione della crisi del debito e la plateale bancarotta dell’Argentina nel 2001. Secondo Joseph Stiglitz solo i paesi che non hanno seguito i pareri dell’Fmi, come la Polonia e la Cina, hanno mostrato crescenti successi economici senza ricorrere necessariamente alle privatizzazioni.
Si presume che la spirale del debito pubblico italiano sia iniziata nel 1981 con la denazionalizzazione della Banca d’Italia. Per quest’ultima, la separazione dal Ministero del Tesoro in favore dell’indipendenza dell’istituto bancario, implicherà la preminenza del mercato sullo Stato in attinenza alle decisioni sui tassi di sconto. Implicitamente l’evoluzione della situazione economica nazionale porta ad una perdita della produttività che, nel corso degli anni novanta si attesterà su una media del 2,6%. Nel 1992 l’assalto speculativo della finanza angloamericana alla lira spinge il paese sulla strada dei tagli e delle privatizzazioni. Ad aggravare la situazione giocheranno le valutazioni negative dell’agenzia di rating Moody’s, oggi familiari per la storia del valzer dello spread che, sommandosi alle azioni di inside trading di pescecani della finanza internazionale (uno su tutti il filantropo George Soros), punteranno al crollo del biglietto nazionale svalutato sino al 30%. Gli effetti di tale ricaduta costringono il governo Amato ad alzare i tassi di interesse sui Bot per non perdere gli investitori, decretando allo stesso tempo l’uscita dell’Italia dallo Sme (Sistema monetario europeo). A nulla varranno i tentativi del governatore della Banca d’Italia Ciampi di difendere la lira; il futuro Presidente della repubblica prosciugherà quasi tutte le riserve dell’istituto nel difendere la moneta nazionale con 48 miliardi di dollari. La grande svendita si verificò proprio perché, a prezzi stracciati, si aprì il «supermercato delle imprese nostrane». Un processo di deindustrializzazione che non ha fatto altro che portare ad una sempre maggiore finanziarizzazione dell’economia.
La storia ritorna sui suoi passi anche ai giorni nostri con gli ulteriori assalti a ciò che è rimasto delle industrie strategiche nazionali. A metà del 2012 si è deciso lo scorporo della Snam dall’Eni, affidando il 30,1% delle azioni alla Cassa Depositi e Prestiti con un’operazione supervisionata dalla Goldman Sachs. Entro settembre 2013 il successivo passaggio sarà quello di cedere il 25,1% a privati azionisti in modo da completare definitivamente la separazione dal cane a sei zampe in ossequio al decreto legge Cresci Italia. Riflettori puntati anche su Finmeccanica, il secondo gruppo industriale italiano dopo la Fiat. Nel 2011, infatti, a causa di una frode fiscale per appalti dall’Enav in merito ad una commissione della controllata Selex, il presidente Guarguaglini è stato costretto a dimettersi. Stessa sorte è toccata a febbraio 2013 al successore Giuseppe Orsi, arrestato per delle tangenti versate al governo indiano riguardo l’acquisto di 12 elicotteri. La ciliegina sulla torta dovrebbe, infine, essere l’operazione di vendita della controllata Ansaldo Sts alla coreana Doosan. Come non detto, le svendite dei primi anni Novanta iniziarono con offensive giudiziarie dato che, il giro di tangenti, connesso allo Scandalo Enimont, fu l’innesco del processo apripista del filone Tangentopoli. Da queste vicende è necessario partire per scrivere un diario del saccheggio italiano.